DISCIPLINE DEL PARACADUTISMO SPORTIVO
FREEFLY
Il volo tridimensionale, o Freefly, letteralmente “volo libero”, si può considerare l’evoluzione del moderno paracadutismo sportivo e si basa sulla capacità di poter utilizzare il proprio corpo durante la caduta libera al fine di creare movimenti e posizioni non solo sul piano orizzontale ma anche in quello verticale. Per questo motivo la caduta libera in questa disciplina si sviluppa assumendo uno svariato numero di posizioni possibili, di cui le principali sono la discesa in piedi o “stand-up”, la discesa in posizione seduta o “sit-fly” e la discesa a testa in giù o “head-down”. La grande differenza rispetto alle discipline “classiche” sviluppate sul piano orizzontale (stile, relativo …) si riscontra nelle velocità raggiunte che possono anche superare i 300 km/h. Sotto l’aspetto competitivo le squadre di freefly sono composte da due elementi più un video-operatore che volando assieme creano coreografie spettacolari che vengono valutate in difficoltà e pulizia di esecuzione.
->Video<-
CANOPY PILOTING - SWOOP
Il canopy piloting, anche conosciuto come swoop è l'arte di pilotare con precisione e accuratezza un paracadute ad alte prestazioni. Recentemente infatti, con lo sviluppo e la larga diffusione di vele sempre più performanti, si è cominciato a sperimentare questa disciplina che prevede l’esecuzione di manovre a vela aperta finalizzate alla perdita repentina di quota al fine di aumentare la velocità verticale e trasformarla, poi, in velocità orizzontale da smaltire in lunghi e veloci avanzamenti sfiorando il terreno o uno specchio d’acqua con gambe e pancia (swoop).
Diversi sono i parametri in base ai quali può essere valutato il gesto atletico di un competitore all’interno della disciplina: la precisione in atterraggio, la distanza percorsa con la planata, oppure la velocità terminale.
Grande merito del canopy piloting è di offrire uno spettacolo che tutti possono vedere dal vivo, a differenza di quanto invece succede con le altre specialità che, svolgendosi in caduta libera, non direttamente fruibili dal pubblico spettatore se non successivamente mediante trasmissione di videoriprese. Nel 2005 si è disputato il primo campionato italiano
->Video<-
WINGSUIT
lo sviluppo di questa tecnica di volo si deve in larga misura ad uno dei miti del paracadutismo: Patrick De Gayardon. Il pioniere francese del volo umano disse un giorno: "la tuta alare introduce nella dimensione prevalentemente verticale del volo in caduta libera una più forte e sensibile tendenza al movimento orizzontale". Oggi la tuta alare vive ancora in un limbo sperimentale: non esiste nessuna competizione ufficialmente riconosciuta; tuttavia sale agli onori delle cronache per record ed eventi mediatici. La particolarità di questa tuta è di essere costituita da due strati di tessuto sovrapposti e cassonati che si gonfiano irrigidendosi per la pressione dell'aria. Perciò si genera portanza, quella forza fisica che permette ad un corpo aerodinamico di sostenersi in aria. Il tempo di caduta libera, se paragonato a quello di un paracadutista tradizionale, è circa il doppio e le distanze che si possono coprire sono impensabili con le tecniche di lancio tradizionali. Chi usa la wingsuit, spesso si dota anche di gps portatile, utile per vedere gli spostamenti in volo rispetto al terreno e studiare a terra i propri progressi didattici.
->Video<-
FREESTYLE
Il Freestyle è una disciplina del moderno paracadutismo sportivo paragonabile alla ginnastica artistica per posizioni ed evoluzioni a corpo libero. Il paracadutista, lanciandosi da una quota di lancio standard di 4500 metri, esegue delle figure acrobatiche prestabilite dove l'eleganza e la fluidità dell'esecuzione, combinate con la creatività, sono elementi determinanti per la valutazione dei competitori. Il freestylist è sempre accompagnato da un video-operatore detto “cameraflyer” o “videoman” che ne immortala le acrobazie a distanza ravvicinata e con lui forma la squadra. La capacità del cameraflyer è determinante nel punteggio della squadra durante le competizioni. Le prove di Freestyle si distinguono in “libere”, dove il performer e il video devono proporre una scenografia di loro invenzione e dimostrare di saper volare insieme e di riuscire ad eseguire determinati movimenti, ed “obbligatorie", salti in cui il performer deve riuscire a riprodurre con la giusta tecnica e in un tempo determinato più figure possibili.
->Video<-
SKYSURF
Lo Skysurf, consente l'esecuzione di movimenti tridimensionali in caduta libera con l'ausilio di una speciale tavola fissata ai piedi. Sfruttando il flusso d’aria, come un cuscino su cui appoggiare la tavola, si effettuano acrobazie molto spettacolari raggiungendo incredibili velocità sul piano orizzontale. L'approccio a questa disciplina avviene per gradi, dopo una buona e provata capacità di volo in posizione verticale. In caso di perdita di controllo, per emergenza, ma anche in fase di atterraggio, la tavola può essere sganciata tramite il sistema a tre anelli a cui è vincolata.
->Video<-
RELATIVO
L'FCL (formazione in caduta libera) detta anche “lavoro relativo” e indicata comunemente con RW (dall’inglese “Relative Work”) è una disciplina di gruppo praticata agonisticamente da formazioni di 4, 8 o 16 elementi. Consiste nell'esecuzione in caduta libera di figure prestabilite sul piano orizzontale, valutate per velocità di esecuzione e precisione. E' una specialità molto tecnica e richiede un notevole affiatamento nel gruppo. Esiste anche l'FCL grandi formazioni, non agonistico, del quale l'attuale record del mondo è stato registrato in Arizona il 12 Dicembre 2002 con una formazione di 300 elementi mantenuta per 7,2 secondi.
->Video<-
CANOPY RELATIVE WORK
Il Canopy Relative Work anche conosciuto come Canopy Formation, è una disciplina di squadra che consiste nel creare figure a vela aperta. Le formazioni a 2 o 4 elementi (2 way e 4 way), a paracadute aperto effettuano prese di mani e piedi sulla vela e sulle bretelle dei compagni, eseguendo figure e rotazioni che vengono riprese da un cameraman esterno alla formazione.
->Video<-
PRECISIONE IN ATTERRAGGIO
La disciplina Precisione in atterraggio consiste in una prestazione individuale a vela aperta. I competitori eseguono lanci da una quota di circa 1200 metri, se a squadra, e 800 metri, se individuale, e puntano ad atterrare, generalmente con il tallone, al centro di un bersaglio prestabilito attualmente di 3 cm di diametro e di colore contrastante e ben visibile. La prestazione viene valutata sulla base della distanza di atterraggio dal centro del bersaglio. Il centro del bersaglio si avvale di un Sistema di Misurazione Automatica (AMD) che misura fino a 15 cm. di errore dal centro, vince la squadra (o l’atleta) che facendo la sommatoria dei lanci, totalizza un minor numero di cm. di errore dal centro.
->Video<-
STILE
In inglese “Style”, in francese “Voltige”. Consiste in un lancio da una quota di 2200 metri (approssimativamente 7000 piedi) con a disposizione circa una trentina di secondi di caduta libera. In questo frangente si deve eseguire una concatenazione di 6 evoluzioni, volteggi, nel minor tempo possibile che consistono in: un giro sull’orizzonte di 360 gradi, l’inversione di esso, una giravolta (looping) all’indietro e la ripetizione di essi . Per ogni lancio ci sono 4 combinazioni d’esecuzione che vengono sorteggiate in precedenza. Simultaneamente ogni concorrente viene ripreso da terra da una postazione video e successivamente giudicato da una giuria. Detta giuria deve aggiungere delle frazioni di secondo di penalità al tempo effettivo di esecuzione asseconda se ogni singola figura non viene effettuata correttamente nel beccheggio (pitch), rollio (roll) e giro di 360 gradi. Vince chi a fine gara, dopo più lanci ha totalizzato un tempo totale inferiore.
->Video<-
UN PO’ DI STORIA….
Si definisce paracadute un deceleratore aerodinamico: questa è la definizione più corretta in campo ingegneristico; in altre parole è il mezzo atto a permettere la discesa a velocità controllata di un corpo in aria, generalmente da grandi altezze. La pratica del lancio con paracadute si definisce aviolancio o paracadutismo.
Leonardo da Vinci ideò il primo paracadute formato da 4 corde legate ad un'imbracatura e che tenevano legata la struttura frenante, costituita da 4 aste di legno legate tra loro con inserti metallici come a formare una piramide le cui facce erano realizzate con tessuto di lino inamidato per aumentarne la rigidità. Il progetto, riproposto un secolo dopo da Fausto Veranzio, non venne, probabilmente, mai realizzato da Leonardo. In epoca moderna un'università statunitense lo ha realizzato nei minimi dettagli: il paracadute ha funzionato ma è risultato poco stabile e non manovrabile; infatti è risultato poco efficace in presenza di vento.
Tra le prime sperimentali applicazioni si possono citare i lanci del francese Lenormand che si lanciò nel 1732 dall'osservatorio di Montpellier e soprattutto quello del francese André-Jacques Garnerin che nel 1797 si lanciò da una mongolfiera, o per meglio dire salito in quota a circa 900 metri a bordo di una mongolfiera che fu sgonfiata e sganciata scendendo a terra tramite un paracadute a calotta collegato al cesto stesso della mongolfiera. Garnerin è considerato l'inventore del paracadute con calotta emisferica.
Il primo lancio da un aereo in volo avvenne nel 1912 quando, utilizzando tecniche ormai perfezionate, il capitano A. Berry si lanciò presso Saint Louis (USA).
Negli anni '20 e '30 numerosi studi ed esperienze portarono a realizzare paracadute efficaci e sicuri, tanto che durante la Seconda Guerra Mondiale il paracadute fu utilizzato non solo come sistema di salvataggio ma anche per il lancio di reparti in zona di combattimento.
Negli anni '50 nacque il paracadutismo sportivo e nel 1963 fu realizzato il primo paracadute ad ala (parafoil) dall'americano Domina Jalbert, che aveva applicato e migliorato le teorie di Francis Melwyn Rogallo[1]. Tale tipo di paracadute, in seguito perfezionato, venne giudicato particolarmente adatto all'attività sportiva.
Generalmente un paracadute si compone di una superficie frenante (vela) la quale viene collegata tramite numerose "funicelle", che a loro volta vengono riunite in bretelle, ad una imbracatura atta ad assicurare il corpo o l'oggetto trasportato; il paracadute è completato dalla sacca di contenimento, dal sistema di apertura e dalla presenza eventuale di sistemi di sicurezza, sempre riguardanti il dispositivo di apertura.
Il materiale utilizzato per la costruzione del paracadute e dei suoi componenti quali funi, sacca ed imbragatura, è generalmente il poliammide. Dalle origini al periodo post-bellico le vele erano realizzate generalmente in seta, sacche ed imbragature in cotone. Il paracadute è anche dotato di un sistema di sicurezza o sgancio rapido chiamato "one shot" che consente di sganciare velocemente le bretelle ed evitare, in caso di forte vento, di essere trascinati dal paracadute dopo l'atterraggio; oppure, quando si atterra in acqua, ci si può sganciare prima dell'impatto con la stessa per evitare che la vela, una volta bagnata, ci trascini a fondo.
I paracadute si differenziano principalmente in base alla destinazione d'uso, sia essa umana o materiale, alla forma della vela (che ne determina in buona parte anche la direzionalità) ed in base al sistema di apertura di cui sono dotati.
Il paracadute a calotta emisferica è di tipo "frenante" e dispone di una manovrabilità nulla o fortemente ridotta; per questi motivi il suo impiego è ristretto all'ambito militare (lanci da bassa quota) o al lancio di materiali. Una sua versione particolare è il cosiddetto paracadute balistico: un paracadute a calotta di grandi dimensioni, assicurato ai velivoli ultraleggeri, che viene espulso mediante un razzo o l'immissione di aria compressa ed è azionabile dal pilota in caso di avaria del velivolo, permettendo un atterraggio di fortuna.
Il paracadute a calotta rientrante è una variante, non più in uso, di quello a calotta emisferica. Si tratta di una velatura piuttosto complessa ed assai difficile da ripiegare a causa delle numerose aperture ricavate nel tessuto. Essa fu studiata alcuni decenni fa per i lanci sportivi; infatti garantiva una spinta maggiore rispetto alle calotte tonde modificate con "tagli" posteriori ed una riduzione della sezione maestra tramite un abbassamento dell'apice della calotta. Ma fu presto sostituita dal paracadute ad ala, che aveva prestazioni notevolmente superiori.
Il paracadute a profilo alare è di tipo "planante" e per questo permette una notevole manovrabilità, che lo ha fatto preferire nell'impiego ludico o sportivo rispetto a quelli a calotta emisferica ed a calotta rientrante.
Il sistema di apertura automatica consiste in un nastro di cotone e nylon antibruciatura, lungo circa 4 m, detto "fune di vincolo" e collegato ad una estremità all'apice della vela tramite un aggancio con nastro a rottura programmata e all'altra ad un moschettone da assicurare al vettore dal quale viene effettuato il lancio del paracadutista o del materiale. Al momento del lancio la fune di vincolo estrae il paracadute dalla sacca e se ne separa quando questo viene completamente estratto (rimanendo agganciata al vettore) mentre il flusso dell'aria fa aprire il paracadute. I paracadute militari hanno all'estremità della fune di vincolo una sacca contenitrice dalla quale fuoriesce la velatura con un ciclo d'apertura obbligato per una sicurezza maggiore. Entrambi i tipi di paracadute, sia a calotta emisferica sia a profilo alare, possono essere dotati degli stessi sistemi di apertura (comandata, tramite fune di vincolo, o manuale mediante maniglia o estrattore hand deploy)
Per l'apertura manuale esistono principalmente due sistemi:
a maniglia (Spring Deploy), in cui la sacca contenente il paracadute è tenuta chiusa da un fermo collegato tramite un cavetto ad una maniglia posizionata o sulla parte frontale destra dell'imbragatura (solitamente nei materiali di qualche anno fa o sui materiali militari) o nella parte laterale inferiore della sacca. Tirando la maniglia la sacca si apre, ne esce un pilotino grazie ad una molla contenuta in esso ed una volta inseritosi nel flusso d'aria questo estrae la vela del paracadute.
mediante estrattore Hand Deploy, (Throw out o Pull Out) in cui, come per il paracadute ad apertura automatica, all'apice della vela è assicurato tramite una fune di lunghezza adeguata (Bridle) un paracadute più piccolo (detto "pilotino") che viene accuratamente ripiegato e riposto all'esterno della sacca, generalmente nella parte inferiore della sacca (Throw out) o all'interno (Pull Out). Questo viene estratto manualmente ed esposto al flusso d'aria nel momento in cui si deve aprire il paracadute e, grazie al flusso d'aria che lo investe, il nastro va in trazione e libera una spina che consente l'apertura della sacca dorsale ed estrae completamente la sacchetta contenente la vela permettendone poi l'apertura (Valido per il Throw Out). Nel caso di utilizzo di paracadute ad ala di elevate prestazioni (piccoli e veloci, tipo Stiletto o Velocity) si usa un particolare pilotino estrattore di tipo collassabile, che ha la caratteristica di richiudersi automaticamente per evitare di fare da freno aerodinamco.
La direzionalità (ove richiesta) del paracadute si ottiene tramite dei comandi a trazione che, modificando la forma o l'inclinazione della vela, permettono di influenzarne la deriva (per i paracadute a calotta) o la planata (per quelli ad ala).
Tra i sistemi di sicurezza più comuni vanno ricordati il paracadute secondario (o di emergenza), dotato di meccanismi che ne facilitano l'apertura a bassa velocità, e la capsula vario-barometrica, dispositivo atto ad azionare il meccanismo di apertura nei paracadute ad apertura manuale al raggiungimento di una quota minima di sicurezza nel caso in cui questa venga attraversata ad una velocità troppo elevata (segno di mancata o imperfetta apertura del paracadute).
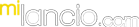
 Prezzi & Promozioni
Prezzi & Promozioni Contatti
Contatti Dove
Dove Torna su
Torna su



 Aerei utilizzati
Aerei utilizzati







